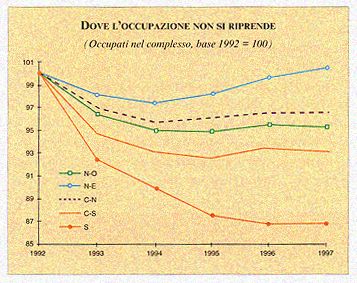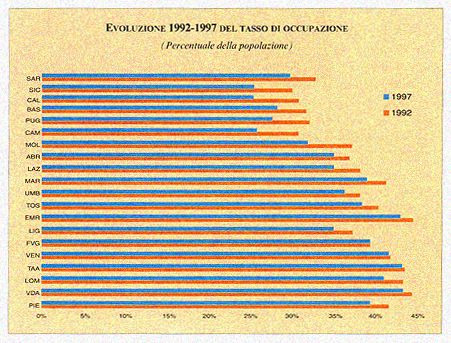Il ritardo economico
del Mezzogiorno rispetto al Settentrione non si colma. Accantonati
gli entusiasmi, alcuni persino "fuori misura", per aver
centrato l'obiettivo europeo, sono ormai le statistiche a riportare
Parlamento e governo di fronte all'evidenza di una recessione che,
avendo colpito quasi tutta la penisola, per buona parte di essa è
ormai distante, mentre continua ad incalzare le regioni meridionali.
La ripresina, com'è noto, non ha ripristinato il milione e
mezzo di posti di lavoro andati in fumo in Italia tra il 1992 e il
1994. Le cause della "ripresa avara" di posti di lavoro
sono note: in primo luogo, l'austerità fiscale che ha compresso
i consumi interni; quindi, le ristrutturazioni che, per la prima volta,
non hanno riguardato soltanto l'industria, ma anche il settore creditizio
e quello del commercio al dettaglio; infine, il prolungato "fermo"
dei lavori pubblici e il taglio dei consumi collettivi, almeno in
termini di tendenza. Si è in questo modo chiusa, o molto ridimensionata,
l'epoca delle assunzioni facili nelle pubbliche amministrazioni. Nei
prossimi anni, l'autonomia di bilancio degli enti locali e una più
massiccia introduzione dell'informatica dovrebbero rendere questa
tendenza strutturale.
Proprio le caratteristiche di fondo della ripresa spiegano perché
non si sia estesa alle regioni meridionali. Qui, dove la distribuzione
dei redditi dipendeva più che altrove dall'occupazione pubblica
e dai lavori pubblici - data anche l'oggettiva arretratezza infrastrutturale
dell'area - l'economia si è dimostrata fino ad oggi ancora
inceppata. Nel Nord, dove la presenza dell'economia privata è
più significativa, dove le imprese producono beni e servizi
destinati ai mercati internazionali, e con livelli di efficienza sostanzialmente
allineati con il resto d'Europa, la ripresa è invece arrivata,
ed è servita per lo meno ad arrestare l'emorragia occupazionale
(Nord-Ovest), permettendo anzi in alcuni casi (Nord-Est) di più
che recuperare i livelli precedenti alla crisi del 1992. La grafica
sintetizza quanto è avvenuto nelle diverse aree. Cominciando
dal Nord-Est, fatti pari a 100 gli occupati nel 1992 in Veneto, essi
non sono mai scesi, al culmine della crisi, sotto il livello di 97,1;
e nel 1998 li troviamo risaliti oltre quota 102. In una regione del
Nord-Ovest, quale il Piemonte, la crisi ha eroso l'occupazione fino
a un livello pari a 94,2; ma in seguito è avvenuto il momento
della stabilizzazione: nel 1997 l'indice è infatti stato 94,7.
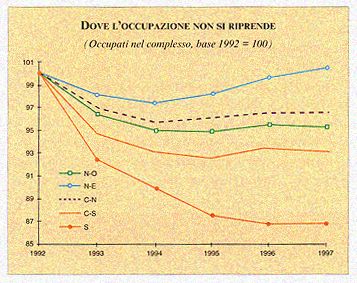
In una regione meridionale come la Calabria, invece, l'emorragia non
si è ancora arrestata. Partendo da 100 occupati nel 1992, nel
1994 (quando il resto d'Italia era al culmine della recessione), l'indice
era già sceso a 88,8 (sei punti sotto il Piemonte, nove punti
sotto il Veneto); nel 1996 era a 83,2 e nel 1997 a 81,9, portando
la perdita complessiva di occupati a quasi un addetto su cinque di
quelli che avevano un posto di lavoro prima della crisi.
Per rendersi conto della gravità della situazione meridionale
si possono infine guardare i tassi di occupazione (e cioè la
percentuale di occupati sul totale della popolazione), molto più
espressivi delle condizioni di ricchezza o di povertà delle
regioni, rispetto a quelli, consueti, della disoccupazione in percentuale
della forza lavoro. Ebbene, in questo campo l'Italia intera è
uno dei fanalini di coda dell'Ocse. Negli Stati Uniti lavora il 49
per cento della popolazione residente. Nel Nord-Italia la stessa percentuale
era del 41,1 prima dell'ultima recessione, che poi l'ha limata al
40,3. Ma nel Mezzogiorno il tasso di occupazione è letteralmente
crollato, dal 30,8 per cento al 26,4 per cento. Come dire che vi è
un produttore di reddito ogni quattro consumatori: la metà
dello stesso quoziente negli Stati Uniti.
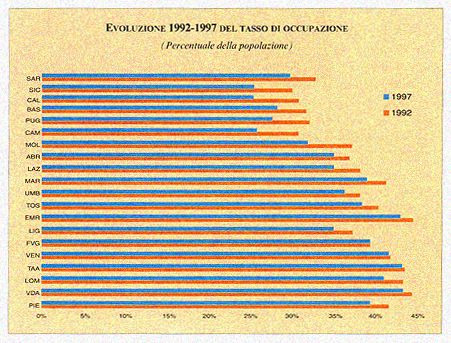
Altro che dossier "Sviluppo Italia" predisposto da Roma.
Altro che "Agenzia Sud"! D'altra parte, il ministro del
Tesoro non ha mai nascosto il convincimento sulla "missione organizzativa"
e di "coordinamento" di eventuali istituzioni del genere.
E del resto esiste già un reticolo di "agenzie che dovrebbero
occuparsi dello sviluppo economico del Mezzogiorno: Itainvest, Enisud,
Spi, IG, Ribs e Ipi, senza contare le Camere di Commercio e le loro
Aziende Speciali. Nelle intenzioni del Tesoro, dunque, non si dovrebbe
andare molto oltre il puro e semplice coordinamento dell'esistente,
e magari cogliere l'occasione per razionalizzarlo, fondendo gli enti
al momento opportuno. Pressoché da escludere, invece, per un'eventuale
nuova Agenzia, una "missione istitutiva" orientata all'intervento
diretto sul territorio e nell'economia. E ciò in contrasto
con le forze di ispirazione marxista, ancora e sempre legate all'intervento
dello Stato-moloch. Né sono sfavorevoli i sindacati, sensibili
agli spazi di negoziato che si sono conquistati, ma dimentichi che
hanno storicamente portato avanti i discorsi salariali e di protezione
dei protetti, cioè di garanzia per le forze occupate, e mai
impegnati seriamente sul piano del progetto di sviluppo del nuovo
lavoro e della nuova occupazione nelle aree meridionali.
L'Iri in questi tempi sta perseguendo obiettivi strategici diversi
dallo sviluppo delle aree depresse. Con l'apertura dei mercati e con
le liberalizzazioni imposte dall'Unione europea, la ristrutturazione
delle aziende pubbliche è diventata più che una necessità.
L'Istituto, perciò, non può farsi carico dei problemi
del Mezzogiorno, perché questo significherebbe rischiare il
fallimento nella missione principale. E questa presa di distanze non
è poi un gran male, viste le esperienze del passato. Né
esultano i promotori delle agenzie esistenti o di quelle recentemente
riformate (come la Gepi, diventata, appunto, Itainvest): essi temono
di non avere il tempo di dimostrare di saper svolgere i loro compiti
e si preoccupano che l'eventuale nuova Agenzia possa sottrarre loro
sia spazi di manovra sia risorse da investire.
Qualche critica è venuta infine anche dagli stessi politici
e amministratori meridionali, e da non pochi sindaci di grandi città,
che paventano il ritorno a Roma delle leve di manovra che le amministrazioni
locali stavano apprendendo ad utilizzare e cominciando ad apprezzare,
specialmente dopo l'ampio ricambio di classe politica e amministrativa
determinatosi con la riforma dei poteri e delle leggi elettorali.
Senza contare che in futuro la politica regionale si farà sempre
di più con il coordinamento di Bruxelles: che senso ha, quindi,
ripristinare un livello nazionale di coordinamento, che anzi la logica
dell'intervento snello, veloce ed efficace tenderebbe ad azzerare?
Il Mezzogiorno, in realtà, ha bisogno di infrastrutture e di
servizi, per superare prima di tutto gli svantaggi che condizionano
il suo sviluppo; e ha bisogno di investimenti privati. Non ha bisogno
di discorsi melensi (e strumentali) sui cosiddetti "costi dei
fattori non competitivi", che poi sono in concreto gli eterni
incentivi per le intramontabili "famiglie" del Nord che
mordono e fuggono, come hanno sempre fatto, vale a dire rapinano legalmente
incentivi fingendo di investire nel Sud, e poi "si danno",
cioè tagliano la corda (è storia semisecolare, per lo
meno), e l'eterna richiesta di gabbie salariali, che esistono da tempi
immemorabili, e che sono tirate in ballo ogni volta che i soliti noti,
secondo tradizione consolidata, chiedono quattrini allo Stato, privatizzando
i guadagni e socializzando le perdite.
Se c'è bisogno di un intervento nel Sud, non è per affidare
a funzionari pubblici la missione di investire, né per dare
altre opportunità di sottrarre risorse senza fare il resto
di niente, come ha sottolineato persino il presidente della Repubblica.
Occorre un'inversione di tendenza nell'antropologia culturale dell'intero
Paese; si deve investire col gusto del rischio, sia pure del rischio
calcolato, da parte dei meridionali, e si deve agire con correttezza,
da parte di chi viene da altre regioni, mettendo fine ai vecchi vizi,
per rendere al Sud un buon servizio, viste le migliorate condizioni
per l'intervento imprenditoriale: senz'altro migliore di quello di
un livello di para-governo in più, e di ricchi accattoni dietro
l'angolo.
|