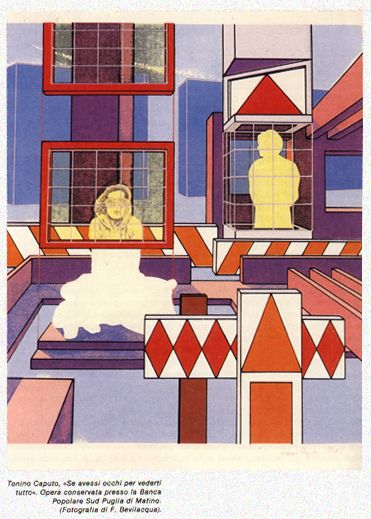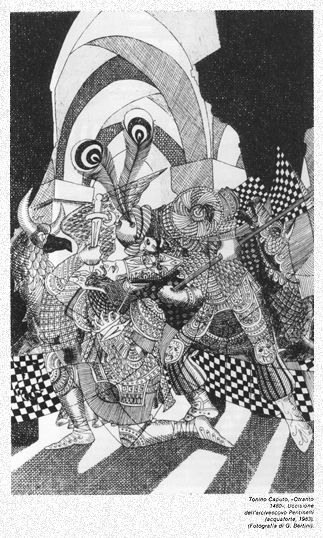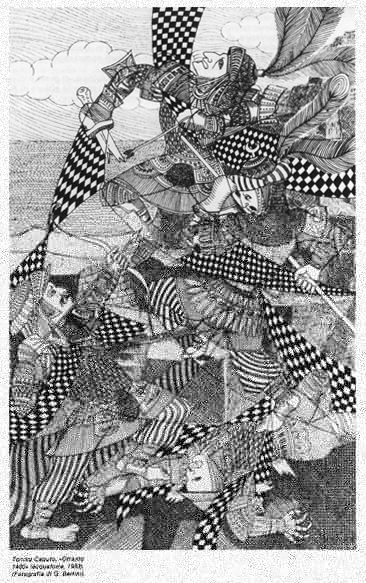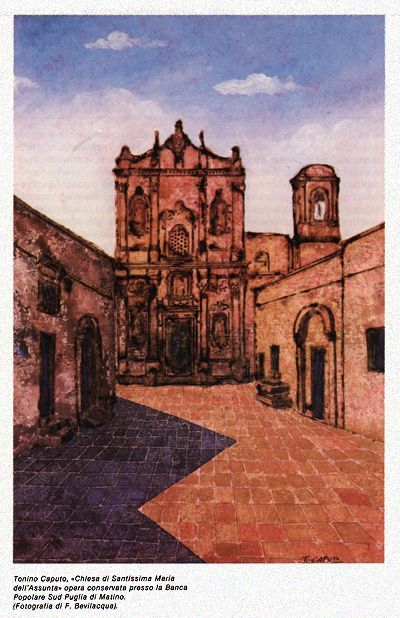Un quadro di Tonino
Caputo porta un titolo che offre la chiave di lettura di tutte le
sue opere, pitture e incisioni: "Come una scatola di ricordi".
Tale difatti è l'immagine che in esse vi appare, inquadrata
in una prospettiva tridimensionale rigorosa, ma scorciata nella profondità
per successivi fondali e quinte trasparenti, quasi strutture mobili
e leggere, facilmente disponibili ad ogni sorta di modifiche ambientali:
una prospettiva partecipe della scena (e Caputo ha una relativamente
lunga esperienza di scenografo, cominciata col teatro di Carmelo Bene)
e altresì della gabbia, anzi più di questa che non della
scena stessa: dico la gabbia come condizione essenziale, dove i ricordi
assottigliano talora i ferri ma sempre li moltiplicano.
Né diversamente si configura l'immagine quando, nitida di contorni
lineari e luminosa di colori come una vetrata, appare circoscritta
dalla montatura metallica di un oblò: identico è il
sentore che ne promana, di cose messe in serbo in qualche punto della
memoria donde sembrano richiamate all'improvviso - ma sicuramente
per una sollecitazione non casuale - e proiettate sulla tela o sul
foglio a popolarne, a volte a gremirne lo scrigno visuale.
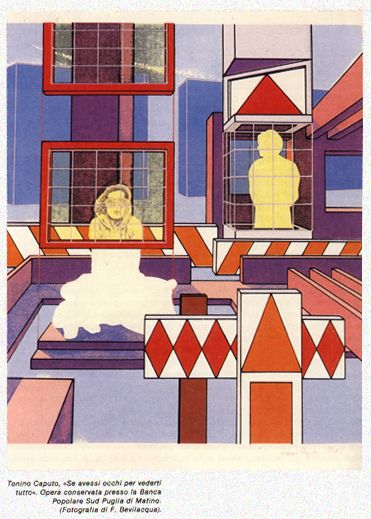
Giustapposte e compenetrate, le cose. E gli episodi, per così
chiamarli: quando interviene esplicitamente la figura umana, che però
non è mai clamorosa quanto lo sono invece gli oggetti "che
assediano banalmente la nostra vita" (lo scrisse Giacomo Devoto
e lo aveva già lamentato Gasparo Gozzi in una nota famosa dell'Osservatore
Veneto) ma si colloca discreta, in trasparenza, più fantasma
che persona, pur se centrale nell'immagine: a specchio - ancora una
volta - della nostra condizione attuale, dove si fa sempre più
arduo tramutare in parole le cose, le vecchie e le nuove tuttavia
crescenti, il lessico restringendosi nelle abbreviazioni utilitarie,
nel l'interiezione e nel gesto, e la dimora dell'uomo snaturandosi
nel contenitore biologico.
Giustapposte, dicevo, e interferenti nell'intarsio sottile; secondo
un ordine che al registro puntuale dei frammenti di realtà
oggettiva conferisce lo scatto non aggressivo della sorpresa.
Non perché gli accostamenti e le sovrapposizioni, o lo spostamento,
che a poco a poco si scopre, dei piani di visione siano inaspettati,
come è calcolato nella iconografia surreale; ma perché
quell'ordine, quella partitura dell'immagine, e quel nitore di esecuzione
che ad ogni elemento compositivo dà il debito spicco, soprastanno
agli esordi (e alle tentazioni) di un racconto di "interno",
che talvolta pare avviato ma che non sarà mantenuto.
La divagazione del racconto apparente nasce con l'immagine, che ha
l'aria della naturalezza (fin nei bersagli, nelle segnaletiche, nelle
compiacenze geometrizzanti o nelle finestre illusorie aperte sull'ultimo
campo pittorico) mentre tende ad esiti diversi, se non opposti, quali
insorgono dalla stessa vivezza della memoria, tanto più operosa
quanto più ha immagazzinato dell'esperienza reale, e perciò
quanto più l'ha decantata e fatta mito con ogni parvenza del
vero.
Dunque, scatole di ricordi. E anche camere ottiche: in una accezione
a latere di quella che indicò le varie cassette e strumenti
e abitacoli di cui si servirono nel passato vedutisti e realisti,
allo scopo di ottenere, per effetto della propagazione rettilinea
della luce, le immagini del mondo esterno. E se qui, a preferenza
d'altri utilizzatori della camera ottica più comunemente conosciuti,
chiamo in causa non direttamente Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnolo,
ma il suo biografo Luigi Lanzi, quando ci informa che il pittore "aveva
in casa camera ottica ove ritraeva que' che stavano in via",
è per quell'aura segreto di spiare il vero senza essere veduti,
e di scoprire nella concentrazione dell'immagine speculare qualità
formali e timbriche, che dal vero nate non sussistono: lo notava Francesco
Algarotti, sulla fine del Settecento, che la camera ottica "non
dando l'entrata a niuno altro lume fuorché a quello della cosa
che si vuoi ritrarre, la immagine ne riesce di una chiarezza e di
una forza da non dirsi". Infine perché la visione dei
reale che ha Caputo è essa stessa una sorta di personalissima
camera ottica, dove tutto ciò che avviene per strada, che ci
condiziona, ci persuade, ci minaccia, ci stordisce attraverso infiniti
richiami estraniandoci da noi stessi, appare filtrato e condensato.

E' quanto già riconobbe Guglielmo Petroni parecchi anni fa,
parlando delle opere di Caputo "colme di allusioni, di affermazioni,
di proteste, nonché di capacitò di esprimere le cose
che ci urgono mentre la civiltà del consumi cerca di soffocarci".
Analogamente Mario Lunetta mise in rilievo, con la saggezza del mestiere,
la scaltrezza e la incisività dei "tranelli ottici"
di Caputo (e le sue ascendenze parzialmente riconoscibili nel Liberty,
ma ben più profonde, a mio parere, nella Metafisica) per concludere
giustamente nella constatazione della "sottile magía"
che scaturisce da una riflessiva "disorganicità semantica",
intendendola in opposizione alla "organicità accademica",
come documento poetico (ma anche morale) del disagio dell'uomo contemporaneo.
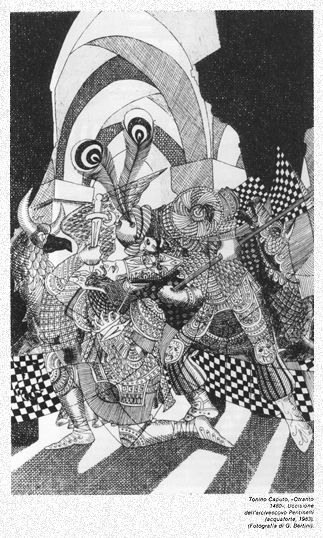
Le stragi che compirono i turchi in Otranto, invasa dal 28 luglio
al 14 agosto 1480 (erano venuti, al comando di Ahmed pascià,
su molti navigli, con migliaia di guerrieri, e cavalli, e grosse bombarde),
culminarono nel supplizio dei comandanti la piccola schiera degli
strenui difensori della città, dell'ottantaquattrenne arcivescovo
Stefano Pentinelli e di coloro che alla salvezza della vita, se avessero
abiurato a Cristo, preferirono la morte, squartati, impalati, decapitati,
i quali furono ottocento, quanti ne tramandano sia le fonti scritte
coeve o di poco più tarde, sia la tradizione popolare, che
da cinque secoli venera le reliquie di questi martiri ammucchiate
negli ossari della cattedrale otrantina.
La materia del sanguinoso evento, epica per il valore con cui furono
affrontati i turchi soverchianti di numero e d'armi, poi combattuti,
corpo contro corpo, nelle vie e case della città, e per la
testimonianza eroica della fede che subito apparve ai relatori contemporanei
ripetere l'esempio dei martiri delle persecuzioni cristiane nell'antico
impero di Roma, ha trovato nel pittore leccese Tonino Caputo una interpretazione
figurale di inventiva schietta e feroce, sostenuta da una consona
percussione di ritmo incalzante, in cinque acqueforti (ora raccolte
in una cartella e presentate da Ennio Francia) le quali hanno tale
una densità di soluzioni narrative, e propriamente un tumulto
di episodi intrecciati o sovrammessi, tuttavia chiarissimi, ciascuno
nella sua parte, che viene da crederle piuttosto riprodotte da un
ciclo unitario di affreschi che ideate per rimanere nell'unica destinazione
della stampa.
Meriterebbero infatti d'essere riprese e sviluppate in composizioni
di vasto respiro sulle pareti di un edificio pubblico - in Otranto,
penso, come sede lor propria - potendovi dar luogo a una prova eccellente
di pittura "di storia", tempestiva oltre tutto nella reviviscenza
attuale - specialmente sentita e attiva nei giovani - di un'arte provveduta,
senza esclusioni preconcette, di quelle virtù di racconto esplicito,
di contenuto "letterario", storico, morale, didattico, e
via distinguendo per comodità di enunciato, giù ritenute
(a torto) inconciliabili col primato del valori formali. I quali d'altronde
non sussistono senza valori formanti; e questi ultimi, insufficienti
di per sé al pari delle buone intenzioni, sono però
indispensabili alla forma d'arte, che sarà tanto più
elevata nella sua purezza finale di immagine contemplata e contemplativa,
quanto più alti, e perciò ammonitori e consolatori,
veri compagni e maestri di vita nel loro significato universale, saranno
i messaggi di cui la forma è, al suo modo legittimo, portatrice
connaturata.
Caputo, già compagno di Carmelo Bene nelle prime affermazioni
smaglianti di un teatro nuovo, cui dette il contributo di scenografie
e di manifesti dal sorprendente estro figurativo (Nostra Signora dei
Turchi era la rivisitazione provocatoria ma autenticamente drammatica
della totale realtà salentina - natura, cultura, memorie -
e soprattutto compiva uno scavo a fondo dell'anima meridionale fino
a trovarne le radici antiche del persistente terrore della decadenza
e della morte, affiancato o nascosto dallo sberleffo esorcizzante
prima che dissacratorio), ha impegnato in queste incisioni, con la
propensione spontanea per i temi cavallereschi già manifestata
in altre incisioni e illustrazioni di libri, un repertorio folto di
imprestiti, rapidi e stravolti, dalla pittura antica e dalla moderna:
dal gotico nordico, spigoloso e costipato, al Picasso di Guernica
con i profili vascolari delle sue teste urlanti avventate.
Interventi molteplici e impreveduti introducono nelle acqueforti di
Caputo mostri surreali alla Ernest, o fanno svettare nello spazio
bianco grandi penne occhiute divergenti dai cimieri come simboli di
superbia e di violenza bestiale (vedi gli uni e le altre comparire
ora nel fitto di una mischia, ora nell'assassinio dell'arcivescovo
dentro la cattedrale appena accennata da un incrocio di archi) o innestano
frammenti di ricordi visivi dei campi di battaglia medievali, ariosteschi,
o naïfs come nella famosa allegoria della Guerra del doganiere
Rousseau.
E dappertutto un brulichìo di scaglie, maglie, piastre, nelle
armature da cui sbucano seminghiottiti i ceffi esangui dei vincitori
e dei vinti, tra una stesa di drappi curvi e rigidi come lame di scimitarre,
ornati da scacchiere: forse vessilli, forse fusciacche o mantelli,
forse gualdrappe simili a quella del cavallo di Guidoriccio, forse,
come è più verosimile, motivi sciabolanti di raccordo
delle diverse fasi di un episodio: con funzione analoga, dunque, a
quella delle porzioni, o isole in figura di vele gonfie, che l'incisore
traccia con un filo sottilissimo, egualmente curvilineo, sulla superficie
della lastra, a raccogliere e a propagare il dominante moto agitato
di membra, d'armi e di gridi.
Presentando la cartella dei Martiri di Otranto, scrive il Francia
come meglio non si potrebbe: "Non ricordo di essermi imbattuto
in un artista tanto vorace, ghiotto e prensile come Caputo pur in
mezzo agli sberleffi, smaniosi di stile e di eleganze, di cui son
gremite le sue composizioni: dal razionalismo geometrico di Mondrian
alle squadrature di Vasarely, dal surrealismo di Ernest all'intimismo
di Bonnard o di qualche altro postimpressionista. Tonino è
capace di trascorrere dalle impronte picassiane ai calchi e alle placcature
iperrealiste, dalle crudezze volumetriche di Léger alle violente
contaminazioni di purissime evocazioni spaziali di Piero della Francesca".
E per le incisioni otrantine in particolare: "Il racconto della
Fuga degli spagnoli dalla città, dell'attacco dei Turchi alle
mura di cinta, dell'uccisione dell'arcivescovo Pentinelli è
condotto con precisione di contenuti e di riferimenti, ma al tempo
stesso con facilità di evocazione da conferire a ogni centimetro
di attività incisoria l'invenzione di un frammento sempre nuovo
e felice. il giuoco delle linee si allarga e s'infoltisce a ridosso
della linea di contorno, quasi un rincalzo costruttivo delle immagini,
mentre i chiaroscuri si alternano per esaltare i valori della luce
e dei volumi... Anche osservata a distanza in modo che i dettagli
scompaiano, la trama dei segni appare in una superficie calibrata
talché anche il frammento ha una sua funzione fondamentale.
Si guardi per questo aspetto L'attacco dei Turchi alla città
dove un elemento centrale e volgare come la scimitarra diventa il
fuoco della composizione, o l'altro della Morte dei capitani Zurlo
e Delli Falconi dove la lastra incisa è come saettata dalle
bande quadrettate per lasciar emergere lo stupendo grigio di fondo".
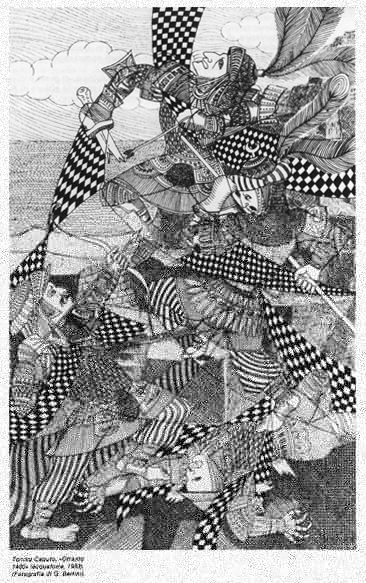
La "Quadratura" o, come si disse più tardi, il "quadraturismo"
fu un genere di pittura caratterizzato dalla prevalenza di architetture
finte intese a spartire e a sommuovere la superficie piana con prospettive
illusorie, specialmente complesse e immaginose in quella stagione
di crisi delle certezze antropocentriche del Rinascimento alla quale
èconvenzione comune dare il nome di Manierismo. Crisi della
posizione centrale dell'uomo nella vita dell'Universo. Crisi, anzitutto,
del principio di autorità, e del sentimento religioso fatto
più intimo, più personale.
Da ciò un'inquietudine intellettiva e morale, una trasgressione
dei canoni classici dell'armonia e delle proporzioni, una molteplicità
di strutture, di profili, di punti di fuga, e un cangiantismo cromatico
e una vibratilità luministica che dal Manierismo entreranno
esagitati nel Barocco e nel decorativismo del Rococò, secondo
una visione del mondo (cui per molti aspetti la nostra assomiglia)
che non può essere contenuta in una concezione spaziale saldamente
unitaria, quale era quella dell'Umanesimo rinascimentale, ma esige
di deflettere, di espandersi, di interferire, di raggiare in direzioni
plurime, già con tensioni fantastiche che sarebbe facile, e
altrettanto improprio, qualificare "espressionistiche" o
"surreali" poiché questi attributi appartengono,
per diritto storiografico, all'arte moderna.
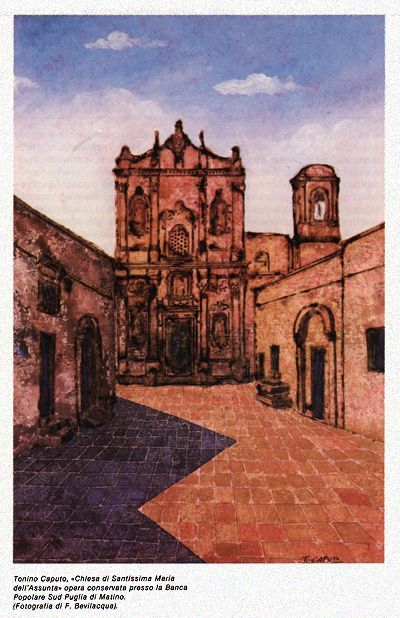
Al di qua delle
ovvie distinzioni di tempo, di cultura, di gusto e di occasioni, e
considerato, prima di ogni altra cosa, come le pitture di Antonio
Caputo, oggi esposte nella galleria napoletana "L'Apogeo",
non abbiano alcun debito da pagare al revival antiquario di così
crescente e talvolta noiosa fortuna, ma stiano tutte ben dentro il
nostro tempo e i nostri pensieri, credo che per esse si possa, forse
si debba parlare di un "dipingere per quadrature": nel senso
della indicazione di una chiave di lettura che faciliti l'intenderle
correttamente nel loro proposito. Il quale proposito consiste nel
dare ordine di necessità e significato verbale al disordine
e alla casualità muta delle cose e degli eventi, col porre
questi e quelle in una spazialità articolata i cui piani, anzi
schermi trasparenti (lo spettatore ne percepisce l'allontanarsi, ma
anche l'improvviso riguadagnare il percorso all'inverso), non contengono
soltanto gli oggetti nella loro tangibilità o nella loro diafana
apparizione, ma ne giustificano la presenza come dati di una realtà
occasionale e mutevole, che l'inquadratura, meglio diremo la griglia
prospettica, ha il compito di stringere in unità organica,
di immobilizzare, e di trasformare in prodotti della fantasia.
I tralicci utilitari di ferro arrugginito, nei quali il pittore racconta
d'essersi imbattuto in una zona disabitata dell'Australia, dove un'impresa
mineraria era sorta e poi abbandonata (già la natura vi aveva
ripreso i suoi diritti accampando una vegetazione lussureggiante attorno
e fin sopra agli scheletri metallici) hanno sostituito e irrobustito,
nelle opere recentissime del Caputo, le antecedenti spartizioni lineari
e prospettiche riconducibili agli studi compiuti nella Facolta di
Architettura a Roma, ma non ne hanno alterato la funzione fondamentale,
ordinatrice e unificante della realtà.
Le hanno aggiunto, se mai, più acuto il sentimento del contrasto
tra l'artificio tecnicistico e la germinazione spontanea della natura:
contrasto non altrimenti risolvibile che naturalizzando il tecnicismo
ossia umanizzandolo, come nel romanzo "Gli Indomabili" di
F.T. Marinetti (specialmente nei capitoli terzo, undecimo e tredicesimo)
dove le metafore, pur svolte fino alle conseguenze estreme, possiedono
evidenti persuasività classiche, con echi, diresti, della poesia
religiosa del Tommaseo: "come il cuore nutre di sangue la foresta
corporale che ha per tronchi le ossa e le arterie, e per fogliame
la carne che trema".
In mezzo ai tralicci meccanici del Caputo non solo si scoprono ma
vivono, imbevuti di luce mattinale, margini inviolati di terra, montagne,
ghiacciai e laghi dal sentore vago di promesse turistiche, si sognano
viaggi e voli mentre si affacciano tratteggiati dalla memoria i piccoli
personaggi della commedia quotidiana o i destinatari dei nostri affetti,
si affollano, di legno o di polpa, i frutti nelle nature morte, e
i solidi geometrici e gli arnesi di lavoro che ai frutti, per la materia
ambigua, somigliano: salgono i rampicanti, e crescono le erbe cui
basta per nutrirsi un cucchiaio di polvere in un crepaccio.
Erbe vere o di plastica? I poveri che le hanno per ornamento non ci
fanno caso, spesso le mettono assieme, le vere e le finte; i visitatori
della mostra non se lo chiedono, coinvolti nel gioco lucido e pensoso
del pittore.